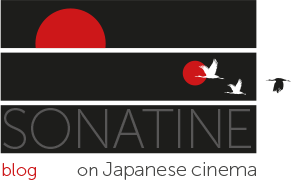BEIJING WATERMELON (Pekinteki suika, OBAYASHI Nobuhiko, 1989)
SPECIALE ANNI OTTANTA
di Jacopo Barbero

Beijing Watermelon (1989) potrebbe apparire, a un primo sguardo, un’opera minore nell’audace filmografia di Obayashi Nobuhiko (1938-2020), tra i pionieri del cinema sperimentale in Giappone e autore, nel corso di quasi sessant’anni di carriera, di alcune tra le più originali e dirompenti opere di genere mai prodotte nell’arcipelago. Per buona parte della sua durata, questo piccolo film d’ispirazione quasi neorealista, incentrato sulla storia vera di un fruttivendolo e un gruppo di studenti cinesi, sembrerebbe aver poco a che spartire con le opere surrealiste e visionarie del regista. Eppure, a poco a poco, appare chiaro come Obayashi intenda realizzare con questo film una delle sue più radicali riflessioni sul rapporto tra realtà, realismo e surrealismo—categorie scivolose e fluide, da rileggere attraverso la lente della Storia, che si insinua tra le righe della sceneggiatura e i tagli di montaggio. Girato tra maggio e luglio nel 1989, nelle stesse settimane in cui in Cina si sviluppava il movimento studentesco poi drammaticamente represso in Piazza Tiananmen, quello di Obayashi è un film-sogno, che re-immagina in chiave utopica le relazioni geopolitiche tra Giappone e Cina e riflette sulla rappresentazione della Storia quando quest’ultima sembra avere la meglio sulle possibilità espressive e visionarie del mezzo cinematografico. In questo senso, Beijing Watermelon è non soltanto uno tra gli esiti più alti e commoventi dell’opera di Obayashi, ma anche una pellicola fondamentale nel panorama del cinema giapponese di fine anni Ottanta, non foss’altro che per il legame inscindibile con il proprio contesto di produzione.
Horikoshi Shunzo gestisce insieme alla moglie Michi il redditizio negozio di ortofrutta Yaoharu, nella città di Funabashi. Un giorno si presenta al negozio uno studente cinese di architettura, Li, che chiede uno sconto visto l’elevato prezzo dei prodotti ortofrutticoli. Inizialmente restio, spinto prima dalla moglie e poi dalla pietà per la visibile denutrizione dello studente, Shunzo inizia a concedere sempre più spesso sconti a Li e all’intera comunità universitaria cinese, con i quali rapidamente stabilisce un rapporto quasi paterno, di amicizia profonda. Li presto torna in Cina, ma altri studenti lo rimpiazzano e il negozio Yaoharu diventa una vera e propria casa e punto di riferimento per gli studenti cinesi in Giappone. Shunzo, sempre più coinvolto, inizia a trascurare il proprio lavoro e la propria famiglia per prendersene cura, arrivando anche a mettere a repentaglio la stabilità finanziaria del negozio e il proprio rapporto con Michi. È però proprio con l’aiuto degli studenti cinesi che Shunzo e Michi riescono a fare i conti con le proprie difficoltà e a ritrovarsi, per poi partire insieme alla volta di Pechino per rincontrare alcuni studenti tornati in patria, in un viaggio al confine tra sogno e realtà.
Beijing Watermelon appare come il prodotto dell’idealismo limpido e contagioso di Obayashi che, come un moderno Frank Capra, sembra voler mettere in scena un possibile mondo migliore, in cui Giappone e Cina possano rielaborare e appianare il proprio rapporto storicamente conflittuale (drammaticamente culminato nella seconda guerra sino-giapponese e nell’agghiacciante massacro di Nanchino). È sorprendente la delicatezza con cui il regista tratteggia il sottotesto politico del film, espresso in forma sussurrata, senza che mai vada a sovrastare l’umanissima storia famigliare e di amicizia interculturale al centro del film. Emblematico è il momento in cui Shunzo mostra a Li le proprie foto di famiglia: tra queste, Obayashi lascia intravedere per un istante l’immagine del padre del fruttivendolo in divisa militare durante il conflitto sino-giapponese, subito celata da Shunzo per non urtare i sentimenti dell’amico. Decenni di conflitti geopolitici e frizioni interculturali sono evocati in questa sequenza da Obayashi, che tuttavia ambisce a immaginare un mondo possibile in cui tutto ciò possa essere messo da parte in nome di una rinnovata amicizia e di un ritrovato rispetto reciproco. Un mondo in cui Shunzo, correndo per provvedere aiuto a Li, possa scandire le parole “Giappone, Cina, Amicizia” con in sottofondo l’ouverture del Guglielmo Tell; in cui Shunzo, Li e Chen possano intonare insieme canzoni in giapponese e cinese, intrecciando le proprie lingue e culture; in cui Shunzo possa acquistare un Chow Chow, cane originario della Cina settentrionale, per colmare la mancanza dei suoi amici tornati in patria. Un mondo in cui persino i giornali giapponesi e il Quotidiano del Popolo, organo del Partito Comunista Cinese, possano celebrare la nascita di nuove forme di amicizia tra i due popoli. “Molti pensano che Shunzo sia strano, ma sta solo facendo il giusto. Di questi tempi è il resto della società ad essere diventata strana,” proclama una cliente del negozio di ortofrutta, che ammira come l’uomo sappia prendersi cura degli studenti e aiutarli a fronteggiare le tante sfide della vita all’estero.
Obayashi opera qui su un terreno scivolosissimo, optando per raccontare una storia di accoglienza idilliaca, che contrasta con molte realtà ben più respingenti nel contesto nipponico: ma non è forse il cinema l’arte dei sogni in cui, talvolta, almeno su pellicola, il meglio della natura umana può manifestarsi? Questa tendenza idealistica del film, che coinvolge e convince per i primi tre quarti della storia, è però infranta nell’ultima parte, quando Shunzo e Michi si recano a Pechino e l’uomo, rivolgendosi alla cinepresa, annuncia che le sequenze cinesi del film sono state girate in un teatro di posa a Tokyo (“un luogo dove i sogni vengono creati su pellicola”), diversamente da quanto inizialmente pianificato, vista l’impossibilità per la troupe di recarsi nella capitale cinese. È allora che gli intertitoli del film, indicanti prima il maggio e poi il giugno 1989, assumono un senso, non tanto nella vicenda del film, bensì in relazione alla sua produzione e agli eventi di Piazza Tiananmen. “La vera coppia del negozio Yaoharu,” spiega Shunzo rivolgendosi agli spettatori, “andò a Pechino nell’estate del 1987, due anni fa. Ma il nostro film non è stato in grado di stare al passo con la realtà. La realtà qualche volta è più potente dei film.” È così che nella parte finale del film i luoghi del tour cinese di Shunzo e Michi (la Grande Muraglia, l’aereo) sono messi in scena come set cinematografici palesemente fittizi, frantumando lo stile realista del film e abbracciando il surrealismo. Quando la realtà non è rappresentabile in termini di realismo, sembra suggerire Obayashi, il surrealismo è l’unica via percorribile per coglierne l’essenza. Tiananmen e i relativi eventi non sono mai menzionati esplicitamente: si manifestano attraverso la propria assenza. È così che il film di Obayashi diviene non solo una parabola idealista sull’amicizia tra Giappone e Cina, ma anche il racconto in absentia del collasso di quello stesso idealismo: quello del film, che non riesce a mantenere il proprio realismo e tono lieve fino in fondo a causa dell’intrusione della Storia, e quello di molti studenti coinvolti nei fatti del 4 giugno 1989. Il finalissimo del film, con gli studenti del film che cantano e suonano malinconicamente in spiaggia nel ricordo dei loro compagni tornati in Cina, è tra i più commoventi che si ricordino: un piccolo requiem per un idealismo infranto, ma anche un segno di speranza per un futuro ancora possibile. È la struggente chiusura di un film in cui Obayashi, proprio come Shunzo veglia sugli studenti, sembra volersi prendere cura delle immagini cinematografiche, chiamate a confrontarsi con le sfide di rappresentazione imposte dalla Storia e dal suo corso imprevedibile.
Titolo originale: 北京的西瓜 (Pekinteki suika); regia e montaggio: Obayashi Nobuhiko; sceneggiatura: Ishimatsu Yoshihiro; fotografia: Nagano Shigekazu; musica: Kondō Tetsuo; interpreti: Bengal (Horikoshi Shunzo, il fruttivendolo), Motai Masako (Horikoshi Michi), Lei Han, Li Juan, Yang Xiaodan, Zhuang Peiyuan, Pan Qinglin, Wu Yue et al. (gli studenti cinesi), Hayashi Yasufumi (Horikoshi Toru), Saitō Haruhiko (Ioka, il farmacista), Sasano Takashi (Yamada, l’immobiliarista), Kino Hana (Otobuji Matsue), Emoto Akira (Teramoto, il negoziante), Ogata Yugi (il bancario), Ōkubo Ryō (Aotani), Iwamatsu Ryō (il poliziotto), Hagiwara Kazunori (Hirai Yasuo), Oshima Hiromi (Horikoshi Yumi), Minegishi Tōru (Dr. Muraki); produzione: Makkusdai, PSC; durata: 135’; anno di produzione: 1989; uscita in Giappone: 18 novembre 1989.